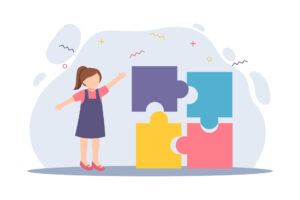Molte persone, dopo aver concluso, o mentre stanno per concludere, una relazione con un partner narcisista cercano di trovare un senso, desiderano capire come e perché “il sentimento oceanico” (come Freud definiva l’amore nel 1931) sia affondato nella desolazione della vergogna, dell’umiliazione, dell’inferiorità o della colpa.
La risposta più semplice che si potrebbe dare è che il narcisista patologico, per sua natura, non è capace di amare né di innamorarsi, concludendo quindi in modo definitivo che ogni relazione con una persona che soffre di questa patologia sia destinata al fallimento.
Tuttavia, la realtà è molto più complessa: la psicopatologia narcisistica, all’interno di una dinamica di coppia, si esprime in molteplici modi e si costruisce attraverso un “scambio di tratti della personalità di entrambi” (Kernberg, 1995, p.165), come un mosaico in cui le tessere vengono disposte insieme da entrambi i partner.
1. La scelta del partner
Domandandosi se un narcisista patologico possa amare, potrebbe essere più appropriato affermare che anche il narcisista patologico sia in grado di instaurare relazioni, ma lo fa secondo un sistema di significati proprio del narcisismo (Bleichmar, 1997). In tale sistema, ogni cosa, comprese le persone, viene valutata su una scala di valore che permette al soggetto di sentirsi superiore o inferiore: così, il partner viene scelto in base a fattori come l’aspetto fisico, la ricchezza, il potere o la fama, alla ricerca di quegli attributi che attirano l’ammirazione altrui, seguendo una logica utilitaristica piuttosto che un genuino interesse per la personalità dell’altro (Kernberg, 2012).
La carenza di curiosità verso la vita interiore del partner, insieme alla mancanza di empatia, porta il narcisista a vedere l’altro come un semplice spettatore, un ammiratore della propria superiorità, da cui esige incessanti lodi. Se ciò non accade, ovvero se l’altro non accetta il ruolo subalterno o, peggio, raggiunge un successo imprevisto fuori dalla relazione, il narcisista reagisce svalutando con rabbiosa invidia ogni aspetto positivo dell’altro. Tipicamente, qualsiasi forma di dipendenza viene negata: la normale reciprocità in una relazione sentimentale viene percepita come uno sfruttamento o un’invasione.
Per il narcisista, la relazione diventa una fonte di limitazioni o di noia, alimentando la fantasia di essere intrappolato o costretto dall’altro.
1.1. L’in-dipendenza del narcisista
A questo proposito, Kernberg, massimo esperto nella clinica dei disturbi gravi di personalità, sottolinea che il narcisista sostituisce il bisogno di essere amato con quello di essere ammirato, vivendo così una sorta di isolamento affettivo, dove: “la dipendenza da un oggetto d’amore diventa impossibile (…) nei narcisisti prevale il timore di essere sfruttati e privati di ciò che hanno, e quindi non tollerano la dipendenza del partner nei loro confronti” (Kernberg, 1995, p.174).
In questo modo, la relazione si carica di risentimento, se non addirittura di odio; l’indifferenza verso i bisogni dell’altro può trasformarsi in indifferenza sessuale, e alla fine i membri della coppia si allontanano.
A questo punto si delineano due scenari possibili. Nel primo, quando entrambi i partner presentano tratti narcisistici (con una tendenza reciproca allo sfruttamento), la relazione, pur con difficoltà, riesce a perdurare. Vengono trovati dei compromessi che colmano il vuoto emotivo e il legame si stabilizza su basi sociali, economiche o incentrate sulla crescita dei figli. Nel secondo scenario, il partner che si sente svalutato decide di interrompere la relazione o manifesta l’intenzione di farlo, cercando di spingere il narcisista a intraprendere una psicoterapia, esplicitamente o meno.
2. Avvicinarsi alla terapia
In alcune situazioni favorevoli, il narcisista si avvicina alla terapia con un sincero interesse, riconoscendo il dolore che causa nel partner e mostrando la volontà di cambiare. La motivazione del trattamento diventa il fattore prognostico principale, e l’età del paziente può essere un elemento che la supporta.
Dopo molteplici fallimenti e la perdita di persone che lo amavano sinceramente, il narcisista può arrivare a mettere in discussione la propria grandiosità e a preoccuparsi della propria salute mentale. In generale, la psicoterapia di un narcisista di quaranta o cinquant’anni ha esiti più positivi rispetto a quella di un paziente più giovane.
Un altro fattore prognostico favorevole è la capacità di riconoscere l’invidia verso il partner, come
sottolineato da Kernberg nel suo libro “Relazioni d’amore”, in cui esplora in profondità le dinamiche di coppia. Quando il narcisista è in grado di associare l’aggressività all’invidia, si tratta di un segno di una crescente consapevolezza delle proprie responsabilità nei conflitti e nella sofferenza altrui. In questi casi, secondo Kernberg, il miglioramento avviene tramite una sofferenza profonda, durante la quale il paziente riconosce e affronta l’aggressività, desiderando contrastarne gli effetti e riparare ai danni inflitti, sia nella realtà che nella fantasia (Kernberg, 1995, p.186).
In situazioni meno favorevoli, però, il narcisista potrebbe intraprendere qualche seduta di psicoterapia sporadica come alibi per mantenere il controllo assoluto sulla relazione. In terapia, i temi tipici del narcisismo—svalutazione, invidia, umiliazione percepita nella dipendenza, competizione, disprezzo e rifiuto di ogni insegnamento—possono emergere anche nei confronti del terapeuta. Tali casi, più complessi, richiedono un lungo e impegnativo percorso. Non è possibile applicare un protocollo manualizzato, ma piuttosto è necessario un processo creativo, alimentato dall’intuizione e dalla curiosità, per entrare con cautela nella vita intima di un altro essere umano.
Conclusioni
Quando si procede con un delicato confronto riguardo alle funzioni difensive che la grandiosità svolge per proteggere una fragilità sottostante, insieme a un’analisi approfondita delle dinamiche familiari e delle esperienze precoci, si giunge a forme più mature di espressione dei bisogni emotivi. In altre parole, la vita ritrova il suo senso, come direbbe Freud. Col tempo, emerge una gratitudine verso la pazienza del terapeuta e si prospetta la possibilità di una dipendenza autentica nei confronti del partner amorevole. In questi casi, l’obiettivo del trattamento diventa quello di trasformare il turbinio delle relazioni in una calma alleanza terapeutica.
Bibliografia
Bleichmar, H. (1997). Psicoterapia Psicoanalitica. Astrolabio, Roma (2008).
Freud, S. (1931). Sessualità femminile. In Opere, vol. 11, Bollati Boringhieri, Torino (1974).
Kernberg, O.F. (1995). Relazioni d’amore. Raffaello Cortina Editore, Milano (1995).
Kernberg, O.F. (2012). Amore e Aggressività. Giovanni Fioriti Editore, Roma (2013)