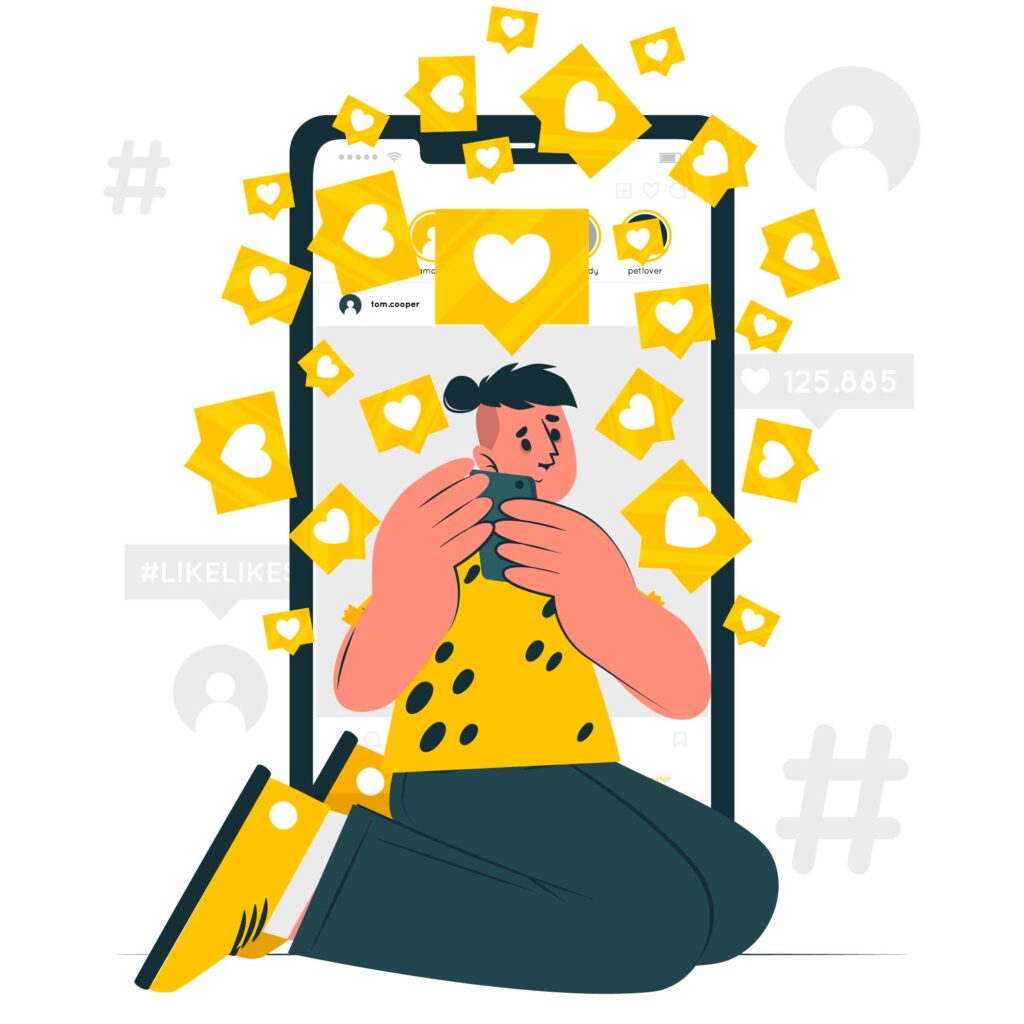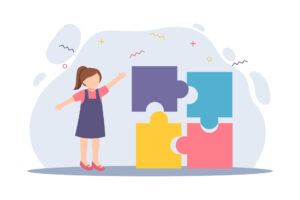La sindrome da iperconnessione può essere definita come una forma di dipendenza che non permette, a chi ne è affetto, di disconnettersi dal mondo digitale. La diffusione degli Smartphone che ci consentono di collegarci alla rete ovunque ci troviamo, ha in qualche modo facilitato in ciascuno di noi un uso eccessivo di Internet, Social e varie App a scopo comunicativo/ricreativo.
Ma nei casi in cui lo scollegarsi provoca un forte senso di disagio, allora ci troviamo di fronte ad una vera e propria patologia. L’iperconnessione inoltre nasconde altri subdoli pericoli. Infatti, oggi, si inizia già in età molto precoce ad entrare nel mondo di Internet con smartphone, profili social e canali youtube, nella lontana speranza di diventare un web influencer o un fashion blogger. Sono figure così ambite che i giovani farebbero di tutto pur di iniziare una “carriera” di questo tipo. Tutto questo spinge i giovani a una la continua ricerca di attenzioni sul web con lo scopo di raggiungere la notorietà.
Like-addiction è la dipendenza che si sviluppa dai like. Chi ne è vittima controlla ossessivamente se le cose da lui postate sui social ricevono o meno il “like”, ovvero il gradimento da parte di chi legge. E’ ossessionato anche dal numero di like ricevuti: tanti like e tante approvazioni accrescono la sua autostima, la sua popolarità e, di conseguenza, la sua sicurezza personale, mentre commenti dispregiativi e pochi like condizionano il suo umore in negativo. Chi sviluppa la dipendenza da like sostituisce la propria vita sociale con la realtà virtuale dei social e delle chat e, a lungo andare, può arrivare ad un vero e proprio isolamento come nel caso degli Hikikomori.
Il fenomeno del like addiction non riguarda comunque solo adolescenti e giovani.
Ma se un po per tutti Internet (e particolarmente i social network), rappresenta un ambiente protetto dove poter dar sfogo al senso grandioso del Sé attraverso la creazione di una nuova realtà virtuale, dove si possono incontrare molti amici, dove ci si può costruire (e ostentare) una nuova immagine e un ruolo, dove ci si può sentire speciali bloccando efficacemente le critiche altrui, esso che impatto ha in una personalità di tipo narcisistico?
Dalle ricerche condotte pare esistere un nesso tra la dipendenza dai social network (e dai like) e il
narcisismo. Questa correlazione risulta essere particolarmente rilevante per ciò che concerne i narcisisti “vulnerabili” ovvero quelli insicuri e con bassa autostima, e un po’ meno per quelli che coltivano una percezione grandiosa di Sè ed hanno una minor tendenza a rifugiarsi dietro ad uno schermo.
Quale potrebbe essere l’antidoto al narcisismo digitale?
La prima cosa che i narcisisti digitali dovrebbero notare è che l’immagine che stanno proiettando non è realistica e quindi l’approvazione che ricevono è diretta ad un riflesso, non a loro stessi. Recuperare l’autenticità è un buon antidoto per scongiurare e fronteggiare il narcisismo digitale dei tempi moderni.
Vivere per posare non è vivere, significa perdere le esperienze più autentiche della vita. Lasciare che l’autostima e l’umore oscillino a seconda della quantità di “mi piace” che ha ricevuto l’ultimo selfie pubblicato implica mettersi interamente nelle mani di una massa che a volte può essere particolarmente crudele. La personalità narcisistica, contrariamente a quanto molti pensano, non è protetta da una forte corazza, ma è una fragile armatura di cristallo.
Il modo migliore per liberarsi del narcisismo digitale è imparare a disconnettersi, per connettersi con il mondo reale. Non si tratta di abbandonare i social network, ma di usarli nella giusta misura.
Grande importanza in quest’ ambito riveste il tema della prevenzione in quanto gli adolescenti odierni sono nati e cresciuti in una società complessa, caratterizzata, tra le altre cose, dalla trasformazione dei modelli educativi familiari, dall’avvento dei social media e dalla diffusione di modelli ideali straordinariamente elevati. Per questi motivi è fondamentale, ma non sempre semplice, riuscire a comprendere quando il rifugiarsi nel mondo protetto del web rappresenti una forma di adattamento alla complessità . Nell’epoca di internet e del narcisismo, i ragazzi e le ragazze sono chiamati ad affrontare la sofferenza derivante dalla distanza incolmabile tra ciò che si aspettavano di diventare e ciò che realmente sono diventati con le trasformazioni portate in dote dai cambiamenti corporei e psichici adolescenziali.
Meno opposizione e più delusione: questa è la caratteristica distintiva degli adolescenti che non si sentono mai abbastanza belli e popolari. Il lavoro da fare in tal senso sarà sulla costruzione di una sana autostima, sull’acquisizione della capacità di gestire in maniera funzionale le proprie emozioni e sulla promozione di una piacevole socialità.
Quando l’intervento avviene a posteriori invece, bisogna ricordarsi che raramente una persona con una dipendenza di questo tipo chiede aiuto in maniera diretta, in quanto si tratta di pazienti poco consapevoli e altamente resistenti, poiché il meccanismo che li attanaglia si basa sulla sensazione del piacere ( come per tutte le dipendenze).
Per questa ragione accade che a richiedere l’intervento non siano le persona interessate, ma coloro che le circondano. Questi ultimi in genere provano in tutti i modi ad ottenere cambiamenti, ma spesso sono costretti ad osservare una situazione che di fronte ai loro occhi peggiora giorno dopo giorno.
Profondamente provati da ciò che subiscono e disperati finiscono per chiedere aiuto.
Come primo passo bisognerà bloccare questi tentativi di soluzione che non hanno prodotto risultati. La collaborazione con coloro che vivono nello stesso ambiente è di rilevante importanza soprattutto quando il paziente si ostina a non riconoscere il problema o se rifiuta il percorso propostogli dallo specialista.
Si indicherà loro di evitare di interferire nella vita del paziente e di limitarsi ad osservare attentamente senza intervenire. In genere si scopre che il problema si alimenta proprio dei tentativi compiuti per affrontalo.
A questo punto lo specialista consapevole della resistenza da parte del paziente, che cercherà di restare legato al piacere viziato che conosce, per evitare il drop-out dovrà muoversi con cautela a piccoli passi e mostrare sicurezza e delicatezza.
Durante l’indagine lo specialista farà in modo di trovare punti di contatto (risorse) per creare una
relazione funzionale e trasformare l’oppositività in collaborazione. Egli riconoscerà le esigenze del
paziente esprimendo comprensione per le sue difficoltà/incapacità/impossibilità, ma allo stesso tempo sarà colui che lo guiderà nell’uscire dal labirinto in cui si trova intrappolato.
Insieme al paziente si concorderanno le condizioni, i tempi e le modalità affinché esso possa riacquisire il controllo che aveva perso.
Si fa in modo che il paziente ritorni ai sani piaceri e, riducendo l’esposizione agli strumenti elettronici e il tempo di connessione, il paziente riprende il controllo di sé, ritorna ad avere relazioni reali, si riappropria del suo tempo: in sintesi, si riappropria della vita che stava sprecando.
BIBLIOGRAFIA
Beck, A.T., Davis, D.D., & Freeman A. (2015), Cognitive therapy of personality disorders, 3rd edition.
NY: The Guilford Press;
Boursier, V., Gioia, F., & Griffiths, M. D. (2020), “Selfie-engagement on social media: Pathological
narcissism, positive expectation and body objectification- Which is more influential?”, Addictive
Behaviors Reports, 100263, published online 2020 Feb 19;
Casale, S., Fioravante, G., Rugai, L. (2016), Cyberpsychology, Behavior and Social Networking,
Università di Firenze, Dipartimento di Scienze Sociali, Psicologia e Psichiatria, vol. 19;
Cesareo, V., Vaccarini, I. (1996), L’era del narcisismo, Milano, Editore Franco Angeli;
Freud, S. (1976). Introduzione al narcisismo, Torino: Bollati Boringhieri;
Lazzeri, M. (2019), “Il Narcisismo digitale e le patologie da iperconnessione”, In State of Mind;
Mitchell, J., Tamir, D. (2012), “Disclosing information about the self in intrinsically rewarding”,
Proceedings of the National Academy of Sciences 109(21):8038-43;
Gabbard, G. (2005), Psychodynamic Psychiatry in Clinical Practice, American Arlington (VA) USA:
Psychiatric Publication.;
Ghezzani, N. (2001), Le eclissi dell’anima, Milano: Franco Angeli;
Kernberg, O. (1978), Sindromi marginali e narcisismo patologico, Torino, Bollati Boringhieri; Kohut, H.
(1971), The analysis of the Self, New York, International Universities Press;
Nadkarni, A., & Hofmann, S. G. (2012), “Why do people use Facebook? Personality and Individual
Differences”, Database APA PsycInfo, 52(3), 243-249;
Panek E.T., Nardis Y., Konrath S. (2013), “Mirror or megaphone? How relationships between narcissism
and social networking site use differ on Facebook and Twitter, Computers in Human Behavior”, Database
APA PsycInfo, 29 (5);
Pearson, C. (2015), “Smartphone use, addiction, narcissism and personality: a mixed methods
investigation”, International Journal of Cyber Behavior;
Rosenfeld, H. (1989), Comunicazione e interpretazione, Torino, Bollati Boringhieri; Rosenberg, K.P.,
Davis, L.C. (2014), Dipendenze comportamentali, N.Y.C., Elsevier;
Rosso, V. (2016), Narcisismo e narcisisti: le antiche origini di un disturbo favorito dall’Era Digitale,
Crescita personale, Psicologia, Sociologia e Politica.
Schimmenti, A. (2017), “Video-Terminal Dissociative Trance: Toward a Psychodynamic
Understanding of Problematic Internet Use”, Clinical Neuropsychiatry, 14, 1.;
Sperry, L. I disturbi di Personalità, McGraw-Hill, 2004;
Zanon, I., Bertin, I., Fabbri Bombi, A., Colombo, G. (2002), “Trance Dissociativa e Internet Dipendenza:
studio su un campione di utenti” della Ret Journal of Psychopathology, vol.