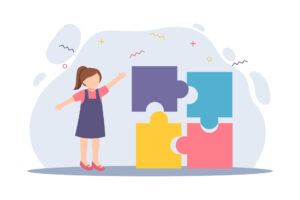Il lutto nel processo normale di elaborazione va incontro ad una graduale riduzione della disforia
e dell’ansia da separazione e una crescente accettazione della morte. Il lutto patologico è caratterizzato da una mancata progressione verso la risoluzione e da una immutabilità del lutto stesso che può protrarsi per lunghi periodi. Nel corso degli anni diversi autori hanno descritto le caratteristiche del lutto patologico, lo sviluppo di tale concetto prende avvio nel 1917 con l’opera di Freud “lutto e melanconia”. Freud descriveva la somiglianza e le differenze tra lutto e depressione. Negli anni 40 Lindermann e Adler (1944) hanno descritto nove caratteristiche della manifestazione del lutto patologico:
- Iperattività senza la sensazione della perdita
- Presentare sintomi appartenenti all’ultima malattia del defunto
- Malattia medica di origine psicosomatica
- Alterazione marcata nelle capacità di relazionarsi con amici e parenti
- Ostilità e rabbia verso persone specifiche
- Comportamento formale e inespressivo con affettività e appiattimento emotivo
- simili alla schizofrenia
- Riduzione durevole delle interazioni sociali
- Comportamenti dannosi per il proprio benessere sociale ed economico
- Depressione agitata
Adler, inoltre, ha contribuito a definire la somiglianza con il disturbo da stress post- traumatico sottolineando due aspetti importanti.
- I sintomi intrusivi (percezioni terrificanti, ipervigilanza, reazione d’allarme, sensazioni di inaiutabilità e di insicurezza)
- I sintomi di evitamento con finalità autoprotettiva (negazione, dissociazione ed evitamento di ricordi dolorosi)
Nel Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5 TR) è stato descritto come condizione patologica il disturbo da lutto complicato e persistente.
Secondo il DSM5-TR i criteri diagnostici specifici sono:
A. L’individuo ha vissuto la morte di qualcuno con cui aveva una relazione stretta.
B. Dal momento della morte, almeno uno dei seguenti sintomi è stato presente per un numero di giorni superiore a quello in cui non è stato presente e a un livello di gravità clinicamente significativo ed è perdurato negli adulti almeno 12 mesi e nei bambini per almeno 6 mesi dopo il lutto:
- Un persistente desiderio/nostalgia della persona deceduta.
- Tristezza e dolore emotivo intenso in seguito alla morte.
- Preoccupazione per il deceduto.
- Preoccupazione per le circostanze della morte.
C. Dal momento della morte, almeno 6 dei seguenti sintomi sono stati presenti per un
numero di giorni superiore a quello in cui non sono stati presenti e ad un livello di gravità
clinicamente significativo, e sono perdurati negli adulti almeno 12 mesi e nei bambini
almeno 6 mesi dopo il lutto:
- Sofferenza relativa alla morte
- Marcata difficoltà nell’accettare la morte.
- Provare incredulità o torpore emotivo riguardo alla perdita.
- Difficoltà ad abbandonarsi a ricordi positivi che riguardano il deceduto.
- Amarezza o rabbia in relazione alla perdita.
7.Valutazione negativa di sé in relazione al deceduto o alla morte (es. senso di auto
colpevolezza). - Eccessivo evitamento di ricordi della perdita.
- Disordine sociale e dell’identità.
- Desiderio di morire per essere vicini al deceduto.
- Dal momento della morte, difficoltà nel provare fiducia verso gli altri.
- Dal momento della morte, sensazione di essere soli o distaccati dagli altri.
- Sensazione che la vita sia vuota o priva di senso senza il deceduto, o pensiero di non
farcela senza il deceduto. - Confusione circa il proprio ruolo nella vita, o diminuito senso della propria identità.
- Dal momento della perdita, difficoltà o riluttanza nel perseguire i propri interessi o nel
fare piani per il futuro.
D. Il disturbo causa disagio clinicamente significativo o compromissione del
funzionamento in ambito sociale, lavorativo o in altre aree importanti
E. La reazione di lutto è sproporzionata o non coerente con le norme culturali o religiose o
appropriate per l’età.
Fattori di rischio
Secondo il DSM 5 TR la prevalenza del disturbo da lutto persistente e complicato si attesta approssimativamente tra il 2,4 e il 4,8% della popolazione e lievemente maggiore nelle donne rispetto agli uomini. E’ una condizione patologica che va distinta da altri disturbi come la depressione e il disturbo post traumatico da stress. Le conseguenze di tale disturbo se non trattato possono essere gravi, la qualità della vita diventa scadente e aumentano i rischi di problematiche mediche come l’abuso di sostanze e alcol, depressione e in alcuni casi suicidio. I fattori di rischio che possono portare ad un lutto complicato possono essere diversi, gli studi sui fattori che influenzano l’andamento di un lutto hanno dimostrato esistono tre categorie di fattori di rischio:
- Condizioni che hanno causato la perdita, ad esempio il tipo di morte
- Caratteristiche della persona che ha subito il lutto, ad esempio tipo di personalità, pregressi disturbi psicopatologici e sofferenza per altre perdite, genere, età, religiosità
- Contesto sociale, ad esempio sostegno sociale, grado di parentela
Nella comunità scientifica gli studiosi affermano che il tipo di morte influenzi profondamente il decorso del lutto, le morti improvvise e traumatiche, rispetto alle morti avvenute dopo una lunga malattia hanno un’incidenza maggiore sullo sviluppo di un lutto complicato.
Nolen-Hoeksema (2000) hanno dimostrato che il coping ruminativo, definito come la tendenza a focalizzarsi in modo passivo e ripetuto sui sintomi di stress e sulle circostanze che provocano lo stress tra cui il lutto può essere un fattore di rischio per il lutto complicato.
Le variabili cognitive possono influenzare l’esito del lutto, ad esempio i pensieri negativi riguardanti se stessi, il mondo, la vita e il futuro generano stati emotivi negativi come la tristezza, la rabbia e l’ansia che motivano ad evitare la realtà e la giusta elaborazione della perdita.
Il sostegno sociale, soprattutto nelle prime fasi di smarrimento e disperazione può essere un fattore di protezione per adattarsi alla perdita, Il mancato sostegno familiare e sociale implica lo sviluppo di un lutto complicato.
Come elaborare il lutto patologico
La Terapia Cognitivo-Comportamentale è un approccio basato sull’evidenza che si concentra su come i pensieri e i comportamenti influenzino le emozioni. Nell’affrontare il lutto, la terapia cognitivo comportamentale risulta essere molto efficace perché tale approccio aiuta a prendere consapevolezza delle emozioni legate al lutto, destruttura convinzioni irrazionali sostituendole con pensieri più realistici e sani, insegna nuove strategie di coping per gestire efficacemente il dolore e aiuta a gestire i sintomi d’ansia e depressione che possono accompagnare il processo di elaborazione del lutto.
Lo sviluppo di una buona relazione terapeutica può fornire un ambiente sicuro e di supporto e il terapeuta fornisce sostegno emotivo e guida il paziente attraverso un processo più sano per affrontare il lutto.
Bibliografia
DSM-5-TR Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. Raffaello Cortina Editore
Freud S, (1917) Lutto e Melanconia. In Opere. Bollati Boringhieri. Torino.
Lindermann E. (1944) The symptomatology and managiament of acute grief. American Journal of Psychiatry 101, p. 141
Nolen-Hoeksema S. (2000) The role of rumination in depressive disorder and mixed anxiety/depressive symptons. Journal of Abnormal Psychology 109,504-511
Onofri A., La Rosa C. (2015) Il lutto. Giovanni Fioriti Editore